Raffaele Lombardo e un’accusa senza prove
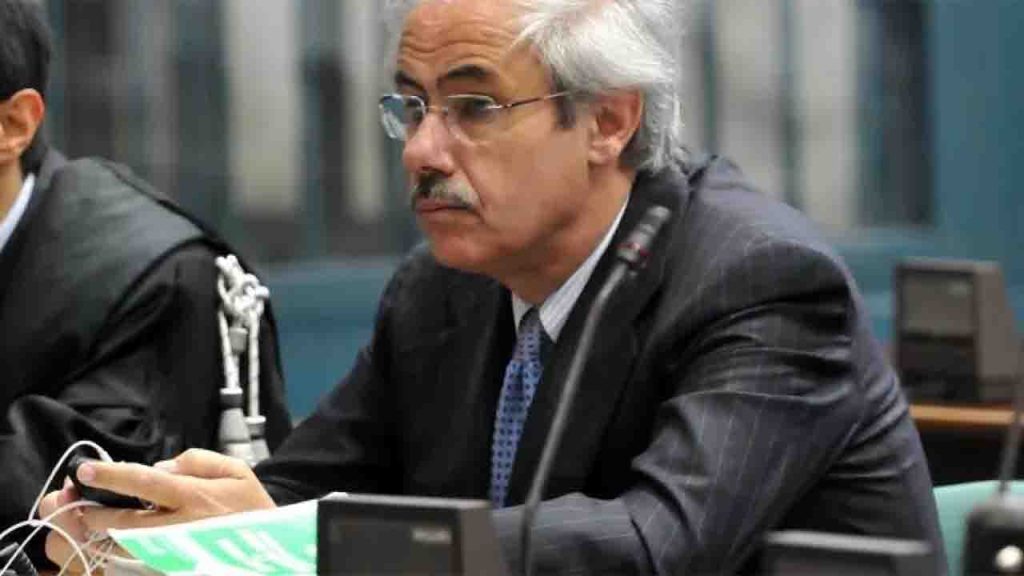
SICILIA- DI CALOGERO PUMILIA
La Corte d’appello di Catania ha stabilito che Raffaele Lombardo non è colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e di reato elettorale. Se fosse possibile rimettere indietro le lancette del tempo si dovrebbero restituire all’ex presidente della Regione i dodici anni trascorsi nelle aule giudiziarie, insieme ad alcuni familiari e segnati dal linciaggio di chi, di solito, non attende le sentenze definitive per giudicare e condannare. Con la medesima, fantasiosa operazione, si potrebbe ripristinare l’assetto politico che i siciliani scelsero nel 2008, stravolto, qualche anno dopo, dall’azione giudiziaria.
Sempre sul filo delle ipotesi di terzo tipo, se la Procura avesse costruito la previsione di reato su presupposti probabili, supportati da prove e riscontri e i giudici di primo grado e di appello avessero deciso su questa base, la vicenda di Lombardo si sarebbe chiusa già da parecchio. Se la procura avesse, poi, tenuto conto che l’obbligatorietà dell’azione penale va rispettata ed esercitata sempre cum grano salis, con elementi che hanno la possibilità di superare il vaglio del giudice terzo, con la cautela che vale per ogni indagato, per ogni cittadino, e che dovrebbe essere ancora maggiore quando, insieme alla vita del cittadino, si rischia di stravolgere quella delle istituzioni. In questi casi la stessa azione dalla quale non può essere esente nessuno, non esistendo intoccabili, potenti a legibus soluti, dovrebbe essere del tutto scevra da pregiudizi di natura ideologica, non dovrebbe risultare da estemporanee e strampalate letture della storia, di quella siciliana in particolare, che, da qualche decennio, si legge su libracci privi di valore scientifico, costruiti con la suspance propria di racconti ad effetto, privata della sua drammatica complessità, banalizzata e portata sul bancone degli imputati, insieme a qualcuno dei suoi protagonisti.
Per Lombardo, come per altri prima di lui, tutto è stato fondato prevalentemente su un postulato che, per sua natura, non deve essere dimostrato, essendo una sorta di articolo di fede. In Sicilia, secondo questo assioma, il voto è controllato totalmente dalla mafia. Lombardo aveva bisogno dei voti per arrivare alle posizioni ricoperte prima nella Provincia di Catania e, poi, alla Regione. Consapevole di questo obbligato passaggio, con la criminalità organizzata egli, parecchio tempo addietro, stipulò un accordo in virtù del quale essa avrebbe riversato su di lui e sui candidati da lui proposti, ad ogni elezione, i consensi, senza necessità di rinnovare ogni volta patti e condizioni. Per la Procura e per i corifei di tutte le Procure, il presupposto risultava talmente solido e scontato da non doversi perdere tempo a cercare riscontri e prove. Se questa è la “Verità” non serve, non è servito, nel caso di Lombardo, nell’iniziale grado di giudizio e in quello di appello, prima del rinvio della Cassazione, prendere in considerazione le sue scelte, neppure quelle, per esempio, di due magistrati come Massimo Russo e Caterina Chinnici, figlia del giudice istruttore ucciso dalla mafia e portati come assessori in giunta, né il rifiuto di costruire i termovalorizzatori, un’operazione, si diceva, sulla quale la criminalità organizzata aveva posto il proprio interesse.
Non ho mai avuto rapporti politici con Lombardo. L’ho visto a volte come uno scostante uomo di potere, puntiglioso nel suo esercizio, anche in quello minuto. Ma questo è un giudizio personale. L’accusa a suo carico l’ho considerata, invece, un ulteriore, approssimativo tentativo di giudicare una parte della storia siciliana, utilizzando materiale di risulta, prendendo a base indagini giornalistiche, spesso improvvisate, tentativi di mettere tutto dentro un frullatore per comporre una poltiglia accattivante, ricca di suspance, vendibile, tesa a beatificare alcuni eroi senza macchia e senza paura. In questo modo, falsificando la storia e rendendo più difficile la lotta a quel cancro che corrode la nostra società, non si riesce a distinguere e a isolare le cellule infette da quelle sane e si finisce per costruire un teatrino nel quale intemerati paladini, da soli o con pochi adoranti adepti, lottano contro un mostro che deve essere rappresentato costantemente con i suoi tratti inalterati, per nulla intaccati nel tempo dalla reazione dello Stato e dal rifiuto crescente della società isolana.















